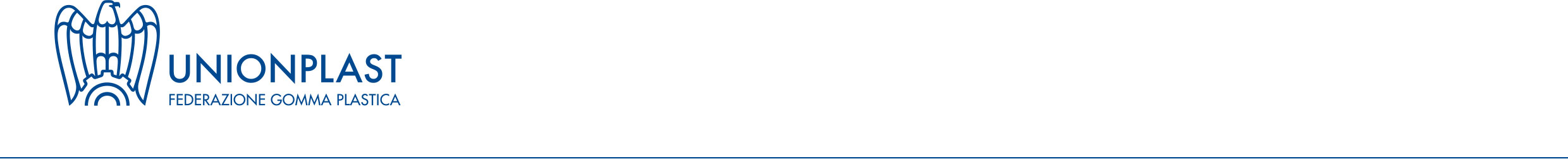La plastica è stata una delle innovazioni più rivoluzionarie del XX secolo, con una miriade di applicazioni fondamentali in ogni campo, dal medicale, all’alimentare, dal settore automobilistico a quello logistico e via dicendo.
La nascita e lo sviluppo di una industria delle plastiche hanno garantito un accesso democratico ai consumi con un evidente superamento delle disparità sociali e hanno garantito vantaggi in moltissimi ambiti.
A mero titolo di esempio, ricordiamo che i dispositivi monouso in plastica hanno ridotto infezioni ospedaliere e migliorato la sicurezza delle pratiche mediche [1]. Il confezionamento in plastica riduce contaminazioni microbiche e prolunga la shelf-life degli alimenti, limitando gli sprechi, una delle principali fonti di emissioni di CO₂ [2].
Le plastiche hanno permesso lo sviluppo della filiera dell’industria agroalimentare; dal campo, ai sistemi di confezionamento, macchine automatiche… ed export del prodotto italiano.
Il minore peso degli imballaggi in plastica rispetto ad altri materiali riduce considerevolmente i consumi energetici e le emissioni da trasporto [3].
Negli ultimi anni, la plastica ha iniziato a soffrire di una cattiva fama e il dibattito sulle microplastiche si è intensificato, con articoli divulgativi che attribuiscono loro effetti sanitari gravi e diffusi. Alcune di queste affermazioni si basano su studi preliminari, spesso con campioni ridotti o metodologie non standardizzate. Recenti articoli divulgativi, tra cui quello comparso sul Corriere della Sera del 27 settembre 2025, a firma di Franco Berrino, hanno riportato dati allarmanti sulla diffusione delle microplastiche nei cibi, nei tessuti umani e persino nel latte materno. Tali affermazioni meritano una revisione critica, alla luce della letteratura scientifica peer-reviewed e delle valutazioni delle autorità competenti.
Il nostro approccio propone una valutazione critica delle prove disponibili, distinguendo tra rilevazione analitica e reale rischio tossicologico, e contestualizzando i benefici della plastica in medicina, sicurezza alimentare e sostenibilità.
Le moderne tecniche analitiche (es. micro-FTIR, spettroscopia Raman) hanno aumentato la capacità di rilevare frammenti plastici di dimensioni micrometriche e nanometriche [4]. Tuttavia, la mera identificazione di particelle in campioni biologici non implica automaticamente tossicità clinica e l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha sottolineato che le evidenze attuali sono insufficienti per trarre conclusioni quantitative sugli effetti sulla salute umana [5].
Molte affermazioni mediatiche derivano da:
– Studi con campioni ridotti (es. autopsie su 12 cervelli di soggetti con demenza) [6];
– Possibili contaminazioni ambientali durante la raccolta dei campioni;
– Assenza di dose-risposta e di studi longitudinali sull’accumulo.
In diversi studi si è voluta cercare solo la plastica tralasciando eventuali altri materiali o si sono riprodotte in laboratorio condizioni/esposizioni impossibili nella vita quotidiana.
In tossicologia, la distinzione tra esposizione e rischio è cruciale: senza dati robusti sulla biodisponibilità, la cinetica e gli endpoint clinici, le associazioni osservate restano ipotetiche, privo di un nesso eziologico.
Ci sembrano quindi estremamente fuori luogo affermazioni come ‘le microplastiche causano infertilità e demenza’, laddove non sussistono prove cliniche solide. Un approccio scientificamente corretto deve distinguere tra segnali preliminari ed evidenze consolidate, per non correre il rischio di produrre letteratura di fantasia.
Ci preme analizzare le dichiarazioni del dr. Berrino, scienziato dal quale ci si aspettano asserzioni scientifiche, a beneficio del lettore proviamo a dare una risposta alle singole accuse rivolte alla plastica:
- “Quasi metà della plastica prodotta finisce in mare”
- Stato delle evidenze: fortemente esagerato. Le stime ONU e UNEP indicano che circa 10–20 milioni di tonnellate/anno entrano negli oceani, pari a meno del 3% della produzione annua, non “quasi la metà”. Ancora più sorprendente la conclusione cui giunge un recente studio dell’Università di Utrecht, da sempre la più riconosciuta nella misurazione dell’inquinamento marino delle plastiche, secondo la quale l’immissione di plastica negli oceani è di circa 500 ktons all’anno (che pur essendo sempre troppe…) sono solo lo 0,1% del totale plastica.
- “Microplastiche nel cervello causano infiammazione”
- Gli studi citati (ad es. rilevazione in cervelli umani) sono preliminari e osservazionali. La presenza non implica causalità. Non esistono prove robuste che le micro/nano-plastiche provochino infiammazione cerebrale nell’uomo.
- “Nanoplastiche nel cervello delle persone con demenza sono 3 volte maggiori”
- Singolo studio autoptico, su un campione molto piccolo (12 casi). Non dimostra che le nanoplastiche causino demenza: potrebbe essere correlazione accidentale o dovuta a fattori confondenti.
- “Microplastiche nel sangue, placenta, latte materno = rischio certo di malattie”
- È vero che tracce sono state rilevate, ma non è scientificamente provato che queste concentrazioni abbiano effetti tossici misurabili nell’uomo.
- “Scaldare una bustina di tè in plastica a 95°C genera miliardi di microplastiche”
- Alcune bustine in nylon rilasciano microplastiche, ma i numeri (“miliardi”) derivano da studi in condizioni estreme di laboratorio, non equivalenti al consumo reale. Non è dimostrato un rischio clinico.
- “Biberon di polipropilene liberano milioni di particelle al giorno”
- Alcune ricerche mostrano rilascio di microplastiche a temperature elevate, ma il rischio per la salute resta ipotetico e non ci sono linee guida OMS che definiscano “dose tossica”.
- “Microplastiche portano cancro, sterilità, disturbi neurologici”
- Queste affermazioni sono speculative. Gli effetti indicati derivano da studi su animali o su cellule in vitro, non da evidenze epidemiologiche solide sull’uomo.
- “Plastica domestica rilascia batteri resistenti e virus”
- Alcune superfici possono ospitare batteri, ma non esistono prove dirette che le microplastiche siano vettori significativi di antibiotico-resistenza nell’organismo umano.
Va infine precisato che, contrariamente alla percezione comune, gli imballaggi alimentari e i comuni prodotti in plastica non sono fonte di microplastiche, se non in misura estremamente ridotta. Secondo l’OCSE, infatti, circa il 90% delle emissioni di microplastica proviene da prodotti non strettamente di plastica [4] affermazione che trova riscontro anche in un articolo pubblicato da Science Advances [9]. Concentrarsi esclusivamente sugli imballaggi rischia quindi di distogliere risorse dai principali driver di inquinamento e demonizzare un settore dove, come in molti altri, la plastica rappresenta una risorsa essenziale, con benefici dimostrati per salute, igiene e per sostenibilità.
Le microplastiche sono un tema emergente che sicuramente merita uno studio e una ricerca approfondita, ma i dati disponibili non giustificano conclusioni apodittiche ed apocalittiche che si alimentano autoreferenzialmente. La priorità è il consolidamento, nei Paesi virtuosi come l’Italia, e lo sviluppo, nei Paesi in cui ne sono privi, di sistemi di gestione e riciclo efficaci, non la demonizzazione del materiale in sé.
Secondo Chris DeArmitt, uno dei massimi esperti mondiali di polimeri e autore di The Plastics Paradox, la narrativa sulle microplastiche è diventata un fenomeno mediatico più che scientifico. Si confonde sistematicamente la presenza con il pericolo: il fatto che tracce infinitesimali vengano rintracciate nel corpo umano o negli alimenti non significa affatto che abbiano effetti dannosi, tanto più che i livelli riscontrati sono milioni di volte inferiori alle soglie di rischio note.
DeArmitt ricorda inoltre che tutti i materiali rilasciano particelle — metalli, vetro, carta etc. Prendersela solo con la plastica è una scelta ideologica, non scientifica. E non tralascia di evidenziare che le microplastiche rappresentano solo lo 0,03% delle microparticelle presenti nell’ambiente.
La conclusione di DeArmitt è netta: oggi non esiste alcuna prova credibile che le microplastiche, ai livelli reali di esposizione, rappresentino un rischio concreto per la salute umana, al contrario, è provato che eliminarla significherebbe aumentare consumo il consumo di energia, CO₂ e risorse naturali.
Il professor Franco Berrino, stimato medico ed epidemiologo, ha dedicato una vita alla prevenzione dei tumori e alla promozione di stili di vita salutari, e il suo lavoro in campo medico merita pieno rispetto. Tuttavia, parlare di microplastiche richiede competenze in chimica dei polimeri, tossicologia ed ecotossicologia, settori in cui Berrino non ha mai condotto ricerche né pubblicazioni scientifiche.
Le sue dichiarazioni su acqua, alimenti e microplastiche derivano da studi altrui, riportati con taglio divulgativo ma senza il rigore necessario per trarre conclusioni scientifiche affidabili. Presentarlo come “esperto di plastica” rischia quindi di creare un’impressione di autorevolezza in un ambito che non è il suo. È possibile rispettare la sua carriera senza attribuirgli competenze che non possiede.
Oggi gran parte della comunicazione su plastica e microplastiche è veicolata da nutrizionisti, naturopati, influencer della salute e altre figure simili, spesso attraverso social media e piattaforme divulgative. Professionisti anche degni di stima nel loro ambito, ma che non possiedono competenze specifiche nel parlare di plastiche. Eppure, la loro autorità percepita nel campo della salute viene spesso interpretata dal pubblico come un sigillo di credibilità scientifica anche su temi tecnici e complessi, creando allarmismo ingiustificato. L’allarmismo vende, ma spesso, soprattutto quando si parla di plastica a questi livelli, non ha basi scientifiche.
Riferimenti bibliografici
- Rutala WA, Weber DJ (2019). Disinfection, sterilization, and control of hospital waste. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases.
- FAO (2019). The State of Food and Agriculture: Food Loss and Waste.
- PlasticsEurope (2021). Plastics – the Facts 2021.
- GESAMP (2019). Guidelines for the monitoring and assessment of plastic litter in the ocean.
- EFSA (2016). Presence of microplastics and nanoplastics in food, with particular focus on seafood. EFSA Journal 14(6).
- Leslie HA et al. (2022). Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood. Environment International, 163:107199.
- OECD (2022). Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060.
- Li D et al. (2020). Release of microplastic particles from food containers by microwave heating. Nature Food, 1:746–754.
- Microfibers in oceanic surface waters: A global characterization. – science.org/doi/10.1126/sciadv.aay8493